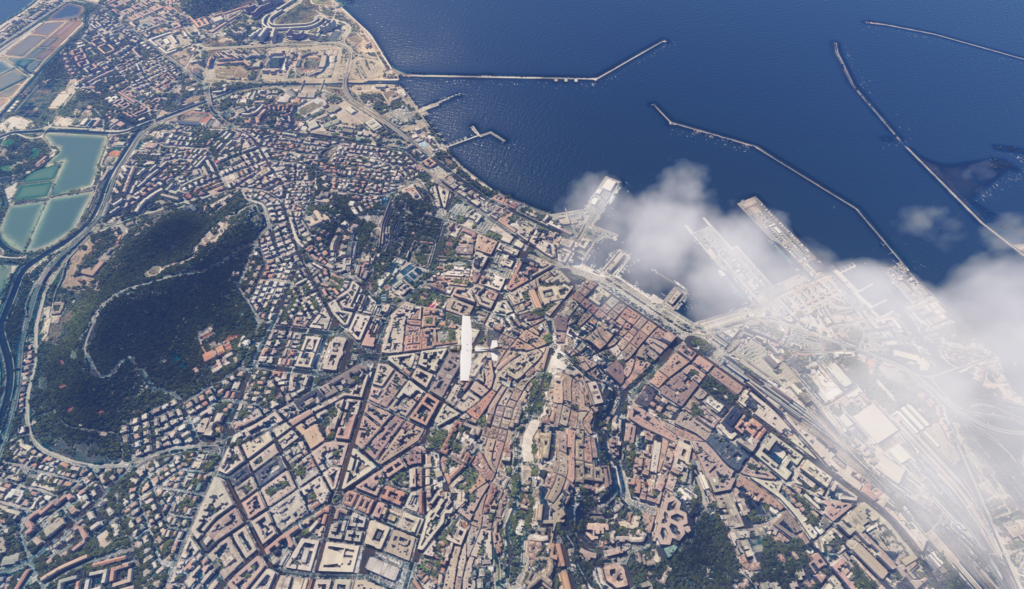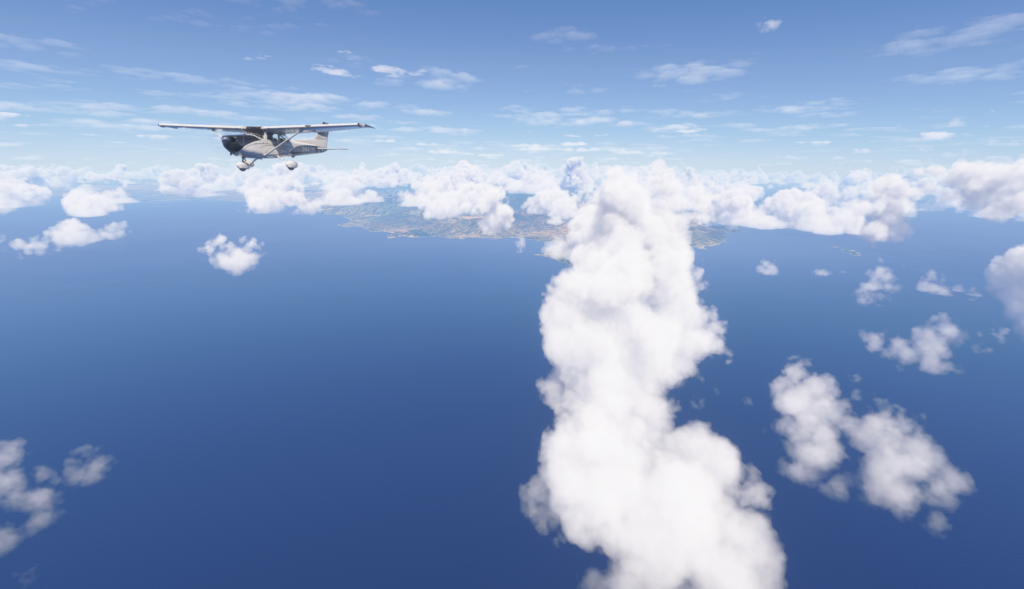17 + Diario di Volo Kasserine
Verso Ovest
Sto per mettere in moto quando noto che la mano mi trema. Sono nervoso e agitato. Non è ansia da volo, non stavolta. È qualcosa che mi stringe dentro, un nodo di pensieri che non vogliono andarsene. Mentre giro la chiave di accensione dell’XCub, penso che Ali, seduto dietro di me in questo piccolo biposto, mi abbia lasciato i comandi per distrarmi, per aiutarmi a respirare un po’. Gli sono grato ma non gli ho detto grazie. Non ancora.
Prima del decollo mi mostra con calma le differenze rispetto al Cessna: i flap si controllano con una leva grande, montata in alto a sinistra, come nelle vecchie macchine agricole. Anche la posizione a terra è diversa: due ruote grandi davanti e una piccola dietro, sembra in punta di piedi. Eppure, appena prendiamo velocità sulla pista sterrata e sconnessa, sento le ruote affondare e ammortizzare dolcemente ogni buca. Poi, quasi senza accorgercene, l’XCub si stacca da terra.
È un attimo. Decolliamo in meno della metà dello spazio che servirebbe al mio Cessna.
Subito dopo la virata verso ovest ho il sole basso sull’orizzonte che colora di rame la campagna, rendendo questo paesaggio diverso da quando sono arrivato.
«Se tutto va bene arriveremo a Kasserine prima che faccia buio» mi avvisa la voce di Ali nelle cuffie.
L’XCub è scattante, agile, leggero. Sto pensando che mi piace pilotarlo quando Ali indica un fiume che brilla in lontananza illuminato dal sole che scivola tra le colline.
«È l’Oued Zeroud» mi dice «È un fiume stagionale che scorre verso ovest. Tienilo alla sinistra. Lo seguiremo per un po’.»
Guardo fuori e annuisco. Il fiume sembra una lama di luce incastonata nella terra.
Prima di decollare davvero bisogna lasciare a terra ciò che pesa dentro.

Grazie
Sorvoliamo una serie di rilievi nei pressi di Ouled Khalfallah. Queste colline, parte della dorsale tunisina, offrono un paesaggio suggestivo. Ali mi racconta che la zona è nota per la sua bellezza naturale e per le tradizioni locali legate alla pastorizia e all’agricoltura.
Subito dopo c’è il Barrage El Haouareb, un piccolo lago artificiale creato da una diga chiaramente visibile. La luce del tramonto, i rilievi attorno, i riflessi sull’acqua calma: tutto contribuisce a creare un’atmosfera incredibilmente rilassante.
Mi rendo conto che, come la moto, anche volare mi aiuta a calmarmi e sentirmi bene.
Prendo un respiro e, un po’ in imbarazzo, rompo il silenzio: «Grazie… Grazie di tutto, Ali. Grazie per avermi permesso di pilotare e di distrarmi… non ci conosciamo da molto ma ti sono grato per tutto quello che hai già fatto e stai facendo per me.»
«Baraka Allāhu fīk» sento in cuffia. Poi mi spiega che è un’espressione tipica: significa “Che Dio ti benedica”. È un modo tradizionale per esprimere gratitudine e benedizione nella cultura tunisina.
Poi mi stringe la spalla con la mano, una sorta di abbraccio silenzioso.
A volte basta volare bassi per sentirsi più leggeri dentro.

Le alture del Mghilla
Il sole si fa più tenue, ancora nascosto tra le nuvole all’orizzonte. Il paesaggio cambia: le colline più marcate si trasformano in rilievi decisi.
«È il Parc National de Jebel Mghilla» dice Ali mentre mi tocca la spalla sinistra e indica la montagna che si staglia alla nostra sinistra.
Mi colpisce la sua imponenza: si alza come un baluardo nella distesa ondulata che ci accompagna da Kairouan. Ali, che sembra conoscere ogni angolo di questa terra, racconta che queste montagne, un tempo frequentate solo da pastori e cacciatori, sono oggi luogo di protezione per aquile reali, lepri berbere e persino iene striate.
«Ma sai qual è la leggenda?» mi chiede con un tono di mistero. «Si dice che qui si rifugiasse un vecchio contrabbandiere che conosceva ogni sentiero e ogni grotta. Lo chiamavano l’uomo senza orme, perché nessuno riusciva mai a seguirlo.»
Sorrido. Sembra una favola ma detta da lui, con la sua strana cadenza italiana, suona come una verità nascosta.
«Ora sali un po’» dice all’improvviso. «Tagliamo il crinale e andiamo verso Sbeitla.»
«Sbeitla?» chiedo, cercando di orientarmi.
«Fidati, ti piacerà.»
Eseguo la manovra guadagnando quota. Lo faccio senza pensarci troppo ma dentro sento qualcosa muoversi. Torna quella sensazione di essermi allontanato da ciò che conosco per andare incontro a qualcosa che mi spaventa e mi risveglia istinti primitivi.
Prendo un respiro profondo, cercando di riprendere la calma.
Ogni quota nuova richiede di lasciare a terra una parte di sé.

Tempo immobile
«Ci siamo.» esclama Ali mentre superiamo l’ultimo crinale e il paesaggio si apre come un sipario su una cittadina dalle case basse. Mi fa cenno di abbassarmi leggermente, così riduco la potenza e ci lasciamo scivolare in una lenta planata.
Davanti a noi Sbeitla sembra scolpita nella terra.
Resto in silenzio per qualche secondo osservando il mosaico di pietre antiche che ho d’avanti. Tutto appare immobile, come se trattenesse il respiro.
«È l’antica Sufetula» dice Ali con voce calma «una delle città romane meglio conservate della Tunisia.»
Da quassù si vedono nettamente i resti del foro, tre templi allineati, colonne ancora in piedi, e l’ombra lunga dell’arco di trionfo che si disegna sulla terra.
«Quei tre templi lì» continua «non sono dedicati a una sola divinità ma a tre: Giove, Giunone e Minerva. Di solito i romani li riunivano in un unico edificio. Qui, no. Qui ognuna aveva il suo tempio. È unico nel mondo romano.»
Mi sporgo leggermente, cercando di cogliere i dettagli: il teatro semi-sepolto, la trama delle strade, i resti delle basiliche cristiane che si distinguono appena tra la pietra gialla e la sabbia.
«Qui si è anche combattuto» aggiunge Ali. «Nel 647 dopo Cristo, gli arabi guidati da Abdallah ibn Sa’ad sconfissero i bizantini. Fu uno degli scontri che aprirono la strada alla conquista dell’Africa del Nord. Dopo quella battaglia, Sufetula non tornò più la stessa.»
Resto in silenzio. La luce radente esalta ogni rilievo, ogni colonna spezzata, ogni traccia lasciata da mani che non ci sono più. È come volare sopra una memoria ancora viva.
«Non è solo un sito archeologico» dice Ali, come se leggesse nei miei pensieri. «È un posto che parla. Devi solo saper ascoltare.»
Faccio un cenno, lasciando che lo sguardo si posi sulle rovine una volta ancora, prima di tornare a puntare nuovamente verso ovest.
Alle nostre spalle, Sbeitla rimane lì.
Piccola e fragile.
Ma più grande di quanto avrei mai immaginato.
Ci sono luoghi che non parlano ma sussurrano. Basta saperli ascoltare dall’alto.

Lampioni
«Segui la P13» mi dice Ali puntando il dito verso una linea luminosa che si snoda nel paesaggio. «Vedi la luce dei lampioni? Ci porteranno a Kasserine.»
Guardo giù e noto la sottile colonna di luce che serpeggia nel paesaggio sempre più scuro. Una strada che non divide ma collega. L’XCub prosegue silenzioso nelle prime luci della sera.
All’improvviso sento una leggera pacca sulla spalla. Ali mi indica qualcosa in alto alla mia sinistra: un piccolo tubicino di vetro sopra la testa. All’interno, il livello di carburante si è quasi azzerato.
«È il serbatoio sinistro» dice con tono calmo. «Quello che stiamo usando da inizio volo.»
Mi volto verso destra, intuendo che ci sia un secondo tubicino. Eccolo: il livello è visibilmente più alto. Mi colpisce la semplicità di questo sistema: due tubicini, due finestre trasparenti che raccontano con chiarezza quanto ancora possiamo volare.
Ali mi indica poi una leva rossa accanto al mio ginocchio sinistro. «Quella, ruotala per cambiare serbatoio.»
Obbedisco. Ruoto con cautela. Ali sorride e mi dà due leggere pacche sulla spalla. Non dice nulla ma il messaggio è chiarissimo: bravo.
Pochi istanti dopo compare Kasserine. La città è lì, distesa tra la terra e le montagne, accesa da mille punti luce che tremano nella penombra. Il tramonto la avvolge con gli ultimi bagliori dorati.
Restiamo in silenzio. Nessuno dice nulla. Perché a volte, quando arrivi in volo sopra una città che non conosci ma che sembra aspettarti, non c’è bisogno di parole.
Ci sono silenzi che parlano più di un debriefing.

Kasserine
Sopra Kasserine l’aria è immobile, il cielo sfuma ora verso il viola e la città sotto di noi sembra sospesa tra la quiete e una memoria che non dorme mai.
«La conosci la storia di questa città?» chiede Ali, mentre indica con un movimento della testa una zona più a sud-ovest.
«So solo che c’è una montagna importante qui vicino.»
«Djebel Chambi. Sì, è la vetta più alta della Tunisia. Lì, alla nostra destra: 1.544 metri»
Mi giro a osservarla. Lui continua: «Ma non è solo la montagna ad aver fatto la storia di Kasserine. Questa terra ha visto la guerra, vera. Quella mondiale.»
Resto in silenzio, incuriosito, lasciandogli spazio per continuare. La sua voce si fa più intensa.
«Febbraio 1943. Le forze dell’Asse, guidate da Rommel, hanno colpito duro gli americani nel Passo di Kasserine. Una disfatta. I soldati alleati non erano preparati alla tattica tedesca. Persero uomini, terreno… e innocenza. Quel giorno si è fatta la storia.»
La città sotto di noi ora ha un peso diverso.
«Dopo quella sconfitta, gli americani cambiarono tutto. Comandi, strategie. E da lì, lentamente, iniziarono a vincere. Ma qui… qui ci hanno lasciato il sangue.»
«Ci sono ancora segni?» chiedo.
«Ci sono. Cimiteri, resti, racconti. La gente non dimentica. Kasserine è una città fiera, dura, ancora oggi. Ha vissuto anche le rivolte degli anni ’80. E durante la Rivoluzione del 2011 è stata una delle prime a scendere in piazza. Sempre in prima linea, anche quando nessuno la guarda.»
Abbasso lo sguardo. Le luci delle case sembrano tutte accese adesso, come occhi che ascoltano.
«Sento un grande ardore dentro di te mentre racconti queste cose, Ali.»
Sorride. «Perché mio nonno c’era. Non alla guerra ma alla rivoluzione del pane. E mio padre, nel 2011, era in strada. Qui la storia non è nei libri. È nelle famiglie. La mia è stata presente.»
Resto in silenzio mentre penso che la sua voce, così enfatica e decisa mentre racconta queste cose, rispecchia il mio stato d’animo. Determinato a lottare per chiudere questa faccenda e proteggere le persone che amo.
Kasserine non è solo un punto d’arrivo. È un nodo, un incrocio di vite, lotte e memoria. E dall’alto sembra voglia darmi forza e coraggio per portare a termine la mia battaglia.
Ci sono luoghi che non si attraversano. Ti attraversano loro.

Sipario
Sembra che il cielo abbia deciso di abbassare il sipario su una giornata intensa. La luce del sole ormai è fioca. Ali mi indica una rotta precisa: «Ci siamo quasi. Dirigiti verso Thélepte.»
Guardo verso l’orizzonte, cercando qualcosa che mi confermi dove andare. Ma vedo solo un piccolo luccichio lontano, come una manciata di luci perse tra le pieghe del paesaggio. Forse un villaggio. Forse una cittadina. Forse solo una suggestione.
Il terreno si fa più ruvido. Arido, segnato da piccole depressioni e colline smussate. Il tipo di paesaggio che non racconta nulla, a meno che tu non sappia ascoltare.
Cerco l’aeroporto ma non lo vedo. Mi guardo continuamente attorno e Ali, notando la mia agitazione, cerca di rassicurarmi.
«Non ti preoccupare» dice con tono tranquillo. «È in basso, in una depressione. Da qui non si vede. Ma c’è.»
Poco dopo la pista compare in una sorta di conca, improvvisa come una certezza che si rivela solo all’ultimo. È stretta, spoglia, quasi invisibile nel paesaggio. Ma c’è.
Sento Ali parlare alla radio, scambiare poche parole in francese con qualcuno a terra. La risposta arriva chiara: abbiamo l’autorizzazione all’atterraggio.
«Fammi fare un giro» gli dico, prendendo leggermente quota. Voglio capire come è orientata la pista rispetto al vento e al terreno.
L’XCub risponde preciso, come se sapesse che questa è la parte in cui si gioca tutto: chiudere il volo bene, con rispetto.
Ali non dice nulla ma so che sta osservando con attenzione ogni mio movimento. Del resto questo è il suo aereo. So che se sbaglio me lo dirà con gentilezza. Ma se atterro bene… forse mi darà una di quelle sue pacche sulla spalla che valgono più di mille parole.
Nel volo, come nella vita, ci sono mani che guidano anche quando restano ferme.

Un atterraggio diverso
Abbasso la velocità agendo con attenzione sulle due leve che ho a sinistra: quella blu, che controlla il passo dell’elica, e quella nera, per la potenza del motore.
Poi, quando la velocità è idonea, abbasso la grossa leva dei flap sopra la mia testa e sento l’XCub modificare il suo assetto. Il silenzio è totale, ora che il motore non ruggisce più come prima.
Mi allineo con la pista. È corta ma so che questo aereo non è il Cessna e necessita di molto meno spazio. So anche che ha il baricentro più arretrato, le ruote grandi davanti e una piccola dietro. Se sbaglio l’assetto, potrei rimbalzare malamente o, peggio, farlo impennare.
Resto concentrato, allontanando tutti i pensieri.
Sento le ruote toccare con una delicatezza che non mi aspettavo. Morbide, grandi, come se affondassero appena nel terreno. Un leggero rimbalzo. Poi la seconda toccata, più stabile. Sorrido. Accarezzo i freni, sento l’XCub rallentare senza fretta.
Due pacche leggere sulla spalla. Le riconosco subito. Ali.
Ho fatto un buon lavoro.
Rulliamo verso le piazzole a fondo pista. Noto subito un dettaglio: alcune tende bianche, pulite, ordinate, con sopra un simbolo medico. Un emblema umanitario.
Ali mi indica con un cenno dove parcheggiare. Eseguo senza dire una parola. Spengo motore, strumenti, luci. Un silenzio nuovo ci avvolge. Scendiamo.
L’aria, nonostante l’ora, è ancora calda. Sospesa. Profuma di terra e vento.
Un uomo si avvicina dal buio della pista. Indossa una pettorina rifrangente ma l’abbraccio con cui accoglie Ali rivela qualcosa di più. Si conoscono. Da tempo.
«Dov’è il grande capo?» chiede Ali in inglese, con un tono a metà tra lo scherzoso e il rispettoso.
L’uomo indica una delle tende bianche, sul margine esterno della pista, lontano da tutto e da tutti.
Ali si gira verso di me. Mi guarda. E senza una parola mi fa segno di seguirlo.
Ci sono atterraggi che segnano la fine di un volo. E altri l’inizio di qualcosa.